Facebook, l’orrore e l’incanto
di Sandra Petrignani
Il Foglio
“Da quando ho letto ‘Se niente importa’ di Jonathan Safran Foer non sono più riuscita a mettere una bistecca in bocca”, mi ha detto un’amica. “Nemmeno io”, ho risposto.
Lo scambio, però, non avveniva a tu per tu o al telefono, ma su Facebook, ed ecco che in pochi minuti ai nostri commenti se ne aggiungevano molti altri di convinti vegetariani o viceversa di irrecuperabili mangiatori di carne, che contestavano le posizioni animaliste dello scrittore americano, e di altri ancora che non avevano mai sentito parlare di quel libro e sarebbero corsi a comprarlo grazie al piccolo, insignificante scambio di battute fra noi.
Perché Fb è così: getti un sasso nello stagno e i cerchi, quando l’argomento è sentito, si allargano a dismisura e la tua chiacchiera a due diventa dibattito pubblico, hai l’impressione di appartenere a una comunità, di essere seduto accanto al fuoco a scambiare racconti della tua vita e di quella altrui come si faceva prima dell’epoca dell’incomunicabilità.
E’ l’orrore e l’incanto di questa geniale invenzione del mondo contemporaneo: tornare a vivere in piazza, e non nella piazzetta del paese, ma in una piazza globale dove puoi farti i fatti del vicino di casa, che non hai mai visto, nemmeno sai che è proprio il tuo vicino di casa, come quelli di uno sconosciuto che vive all’altro capo del pianeta.
Non era questo all’inizio il progetto del giovane inventore Mark Zuckerberg, studente di Harvard che, con un paio di amici, nel febbraio del 2004 voleva solo mettere in contatto fra loro gli iscritti alla sua università perché potessero scambiarsi alla grande notizie utili allo studio, prendere appuntamenti, dividere i costi di un appartamento.
Fare, insomma, via rete ciò che facevano anche prima stringendo amicizia sui prati del campus o nei frequentatissimi baretti di Harvard Square o affiggendo bigliettini nelle varie bacheche dei vari istituti. Non è certo un caso che la pagina-profilo su Facebook si chiami, appunto, “bacheca” (wall) e che il sito prenda il nome dall’annuario che raccoglie le fototessera degli studenti, il face book con cui abbiamo familiarizzato attraverso tanto cinema americano.
Non immaginava il geniale Mark dal viso cavallino e le guance implumi che nel giro di dieci anni avrebbe invaso la terra intera e superato i 500 milioni di utenti per un fatturato di 1,1 miliardi di dollari. Perché oltre agli harvardiani si sono mano mano registrati al servizio anche gli studenti di altre università americane, e poi quelli europei e poi quelli delle scuole superiori e a un certo momento (alla fine del 2006 più o meno) non erano più solo studenti, ma dai tredici anni in su chiunque dotato di duttilità tecnologica poteva connettersi a Fb.
Cosicché, inevitabilmente, i contenuti iniziali finivano con il modificarsi. “Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita” è lo slogan del sito. E forse per questo i detrattori pensano, senza saperne molto, che “ritrovare i vecchi compagni di scuola” ne sia lo scopo principale. “Cosa vuoi che me ne importi di riprendere i rapporti con persone che conoscevo a sei anni! Se le ho perse di vista ci sarà una ragione”, mi dicono amici perplessi e ostili alla mia passione per il social network secondo solamente a Google, stando al numero di visitatori.
Ma che c’entrano i compagni di scuola! mi tocca spiegare ogni volta: ne ho ritrovata una sola di compagna di scuola, due va’. A parte il fatto che sono proprio le due compagne di scuola che mi fa piacere frequentare, Facebook non è una triste festa planetaria di “ex amichetti d’asilo cinquant’anni dopo”, tanto è vero che gli utenti più attivi sono giovani e giovanissimi, che l’asilo se lo sentono troppo vicino per provarne nostalgia. Ma allora che diamine è questo Facebook? E soprattutto: “Cosa ci trovi di così attraente?”, mi viene chiesto con incredulo sconcerto ogni volta che mi dichiaro dipendente dal popolare “gioco” di società virtuale, che sta ridisegnando il modo di stringere relazioni fra le persone.
Buone domande a cui non è per niente facile rispondere. Ci proverò cominciando dall’inizio della mia, chiamiamola, “militanza feisbuchiana”. Innanzitutto devo spiegare che non appartengo alla pattuglia della prima ora: mi sono affacciata sul sito, per altro frenata dalle stesse resistenze e dagli stessi sospetti dei miei amici più critici, solo un anno e mezzo fa, quando una giovane editor mi convinse che per uno scrittore far circolare su Facebook i propri libri è un ottimo investimento pubblicitario. Insomma ero animata, lo confesso, unicamente da spirito affaristico e se non fosse stata lei stessa, quella intraprendente ragazza, a iscrivermi mostrandomi quanto fosse facile entrare a far parte della modernità tecnologicamente più avanzata, sarei ancora lì a chiedermi: mi butto o non mi butto? Mi sono buttata.
E, subito lasciata a me stessa, ho capito che potevo nuotare senza problemi anche ignorando totalmente i segreti di parole misteriosissime come “tag” (con annesso verbo “taggare”), come “poke” (con annesso “pokare”). Anzi ancora oggi qualche dubbio lo conservo e sulla questione “taggare” non ho ben capito se è l’andare importunando le persone imponendo loro la lettura di nostre “note” o se, più semplicemente, il tag è la scrittura del loro nome dentro una fotografia in cui compaiono o se l’una e l’altra cosa.
Il risultato non cambia: ho imparato a taggare a più non posso nell’una e nell’altra direzione. Quanto al poke, me l’ha spiegato mio figlio, per motivi generazionali più a suo agio di me dentro l’universo dei naviganti internettiani. “Poke” mi ha detto “è fare così” e mi ha dato con un dito una spintarella sulla spalla. E dunque? ho chiesto continuando a non capire. “Ma sì, è un modo per attirare l’attenzione. Tu mandi un poke a qualcuno e quello si accorge di te. E’ come un saluto”. Ma insomma qui non siamo l’Accademia della Crusca, non tuteliamo l’integrità della lingua e, dunque, se proprio volete saperlo, quando qualcuno su Facebook riceve un poke, e lo ricambia, per una settimana consentirà al pokante di curiosare nel suo profilo (o bacheca che dir si voglia).
E adesso veniamo al nocciolo: cosa succederà mai su queste “bacheche”? Di tutto, di più. Qui sta il bello: tu credi di piegare ai tuoi interessi l’intero trappolone convincendo a comprare i tuoi prodotti i pochi o tanti “amici” che sei riuscito ad accalappiare in rete, e presto, se non subito, la trappola scatta su di te.
E se non scatta, mi chiedo, che ci stai a fare su Fb? Se non scatta, non ti diverti. Se non scatta, se non ti fai invischiare, se stai lì a difenderti e a fare il sostenuto, se non dai qualcosa di te di autentico, se sei un tipo freddo che gli altri devono stare al loro posto e guai se si avvicinano, se sei pauroso di tutto e di tutti e fai il prezioso, sempre con la puzza al naso, sempre lì a valutare “chi mai sarà questo sconosciuto/a che mi chiede l’amicizia, gliela do o non gliela do”… se insomma, come certi innamorati che non vogliono scoprirsi e fanno gli indifferenti finché l’amata si scoccia e sceglie un altro, stai su Facebook con l’aria di non starci, con la paura di perdere tempo, con il contagocce, non saprai mai cosa può succedere fra una bacheca e l’altra, nella ragnatela indistricabile di rapporti virtuali che qualche volta (spesso) diventano reali e di rapporti reali che, diventando virtuali, finalmente si approfondiscono.
Mi rendo conto che, a chi non lo pratica, non ho ancora chiarito niente del complesso sistema di relazioni messo in campo da Fb. E allora un poco di casistica. Una volta iscrittisi a Facebook si deve andare a cercare nomi di persone note (solo a noi o in generale) già interne al “gioco” chiedendo loro l’amicizia per costituire un proprio gruppo di persone con cui interagire. Ognuna di queste persone possiede un suo tesoretto di nomi (corredati di simboli, foto, disegni che le rappresentano) che possono essere messi in comune, previo accordo degli interessati.
C’è chi cerca solo persone che conosce già nella vita vera, o comunque garantite da presentazioni affidabili, e chi si lascia incuriosire dagli sconosciuti, purché simili a lui, e chi non si fa impressionare negativamente neppure dagli elementi che nel suo gruppo sociale vengono generalmente banditi: un modo ruspante di proporsi, una battuta ingenua, una foto scollacciata, un tatuaggio selvaggio… Inutile dire che a maggior apertura corrisponde più grande divertimento. Ma siccome la natura umana è selettiva e conservatrice e simile chiama simile, ecco che poi all’interno anche del più sterminato campo-amicizie finiranno per legare solo quelli che hanno gusti, idee politiche, cultura analoghi. Insomma uno può arrivare a totalizzare anche cinquemila amici (limite massimo consentito) ma a interagire sul serio e assiduamente è grasso che cola se saranno in cinquecento.
Ancora un po’ di esempi: c’è chi lancia temi di discussione e chi va a ruota. C’è chi ama polemizzare e chi butta acqua sul fuoco, c’è chi discute solo di politica e chi propone spezzoni di film, canzoni, brani teatrali (attraverso i video YouTube) o proprie immagini. Chi scrive poesie e le sottopone al giudizio della comunità, chi invita a feste, presentazioni di libri, degustazioni, sfilate di moda e chi cerca appartamenti al mare.
Chi scrive articoli per i giornali e li rilancia sul suo profilo (il suo wall) dove avrà il piacere di vederli discutere da una massa di gente, spesso molto agguerrita e intelligente, non sempre e comunque adorante e acritica. Chi si mobilita per qualche (giusta?) causa, chi denuncia, chi informa, chi chiama a raccolta per scendere in piazza, chi fa propaganda elettorale (uno stuolo – in genere noioso – di politici noti, notissimi o alle prime armi accompagnati da slogan e bandiere), chi dà lezioni di cucina, chi sistema cani randagi, chi commenta in diretta una trasmissione televisiva, chi si sfoga per i tradimenti del coniuge e chi cerca nuovi innamorati/e.
Chi non ha inventiva e si affida a scambi preconfezionati con invii (virtuali, ma a pagamento) di mazzi di fiori, orsacchiotti, cuoricini… Dove altro puoi andare di corsa a dirne quattro a David Sassoli perché ha votato a favore di una vergognosa legge sulla vivisezione al Parlamento europeo (e lui sta faticosamente cercando di spiegare le sue ragioni) o congratularti con Vito Mancuso, se sei d’accordo con le sue posizioni, perché lascia la Mondadori?
Fai amicizia in quattro e quattr’otto con Michela Murgia e le dici quanto ti è piaciuto il suo libro e lei ti risponde un ovvio “grazie”, o qualcosa di articolato dedicato esclusivamente a te, se sei stato capace di interessarla (perché, per esempio, Michela Murgia, grande esperta di blog e comunicazione in rete, è di quelli che non si risparmiano: non lo faceva prima da semisconosciuta, non lo fa adesso che ha vinto il Campiello). Ma, soprattutto, Facebook dà i superpoteri. Questo è il segreto del suo successo.
Diventi ubiquo: puoi festeggiare il matrimonio di un tuo lontano parente in uno sperduto villaggio degli Stati Uniti e insieme trovarti a Ibiza a condividere la vacanza di tua sorella. Ti fai invisibile: puoi controllare i figli che si danno appuntamento per il sabato sera e verificare se il tuo amante fa il cascamorto con le altre. Hai superudito, supervista, superenergie. Puoi cambiare personalità, identità, persino sesso senza ricorrere alla chirurgia.
Eppure su Facebook vengono a galla pregi e difetti, la generosità o la supponenza dei vari tipi psicologici, che si tratti di soliti noti o di imprevedibili ignoti. C’è chi viene inseguito e chi insegue in modo anche indipendente dalla notorietà acquisita altrove. Non che il mito del successo non alligni in rete come negli altri mondi, ma la possibilità di strappare la maschera e guardare cosa ci sia dietro al personaggio famoso è a disposizione di chi non si lasci incantare.
E la bella sorpresa è che di gente autonoma, gentilmente critica, attenta e sensibile è pieno il mondo di Fb quanto di cretini, invadenti e opportunisti. Ma con un clic puoi liberarti dello scocciatore senza strascichi.
E adesso la domanda delle domande: è davvero una rivoluzione il modo di stare insieme su Facebook o solo un’illusione collettiva di amicizie inesistenti, di compagnie fittizie? Sposta qualcosa nell’inconscio collettivo, nel modo di informarsi e costruirsi idee autonome su ciò che ci circonda o non sarà la pericolosa anticamera di uno spropositato narcisismo alla portata di tutti, un’immaginaria fabbrica di scatenati egocentrismi, un contagiarsi inutile per blaterare rivendicazioni al vento, un’invasione senza limiti della privatezza, del segreto delle persone? Che ricadute avrà tutto questo sulla vita vera della gente? E, soprattutto, qual è a questo punto la vita vera e quella falsa?
Vale di più avere un vicino di cui non sappiamo niente e al quale non rivolgeremmo mai la parola sul pianerottolo perché è di destra e noi siamo pervicacemente di sinistra, o ritrovarselo amico su uno schermo imparando che fiori preferisce, chi ha amato alla follia, di che cosa sta soffrendo e scoprirci capaci di una viva simpatia perché come noi si getterebbe nel fuoco per salvare un gatto? In un recente articolo sul Corriere della Sera Maria Laura Rodotà riferiva le tesi di Stephen Coleman, un sociologo che a Londra studia la “cittadinanza digitale” e che non è per niente ottimista sulle ricadute sociali dell’impegno dimostrato in rete dagli under 40 (non più precisamente riconoscibili nelle tradizionali categorie di sinistra e di destra): si mobilitano su temi specifici ma senza capacità di organizzare una militanza attiva, agitano opinioni in rete facendo proseliti senza incidere sul reale perché non sono in grado di elaborare proposte politiche concrete.
Prova ne sia la parabola di Obama, eletto grazie all’appoggio dei social network da persone che non sanno andare oltre la configurazione del “fan” e che non hanno elaborato strategie per sostenerlo nel tempo.
Ora, siccome Maria Laura Rodotà è anche un’attiva presenza su Facebook con un parco amici di poco inferiore ai fatidici cinquemila, il suo articolo ha subito suscitato una discussione in rete rilanciata da un altro giornalista e scrittore, Fabrizio Falconi, portatore di una visione meno pessimista, e i commenti si stanno moltiplicando.
Il famoso sasso nello stagno. E se ogni causa ha un effetto, anche gli infiniti cerchi provocati dal quotidiano dibattito feisbuchiano da qualche parte andranno a parare. La comunità digitale avanza, né più buona né più cattiva di quella reale, né particolarmente diversa negli usi e costumi, ma avanza, con qualche inevitabile, magari per ora impercettibile, slittamento verso il nuovo.
Ora, siccome Maria Laura Rodotà è anche un’attiva presenza su Facebook con un parco amici di poco inferiore ai fatidici cinquemila, il suo articolo ha subito suscitato una discussione in rete rilanciata da un altro giornalista e scrittore, Fabrizio Falconi, portatore di una visione meno pessimista, e i commenti si stanno moltiplicando.
Il famoso sasso nello stagno. E se ogni causa ha un effetto, anche gli infiniti cerchi provocati dal quotidiano dibattito feisbuchiano da qualche parte andranno a parare. La comunità digitale avanza, né più buona né più cattiva di quella reale, né particolarmente diversa negli usi e costumi, ma avanza, con qualche inevitabile, magari per ora impercettibile, slittamento verso il nuovo.
Il visconte di Valmont e la marchesa di Merteuil avrebbero di che sbizzarrirsi manovrando un’arma potente come il computer e un teatro umano vasto come quello di una rete digitale per manipolare i destini amorosi delle loro vittime. Sono relazioni pericolose, molto pericolose, tanti scambi fra amanti spiati da mogli e mariti gelosi sotto false identità (chiunque può aprire un profilo con un nome di fantasia), ma si sa anche di storie d’amore risbocciate fra partner di vecchia data che avevano ripreso ignari a corteggiarsi, sotto altro nome, riscegliendosi inesorabilmente fra sterminate nuove possibilità…
Chissà se Zuckerberg aveva previsto almeno questo nell’inventare la sua micidiale macchina: la possibilità di moltiplicare gli scenari delle vicende sentimentali, complicarne gli strazi, pervertirne le delizie, centuplicare gli equivoci. Nell’altalenante pendolo fra virtuale e reale, se un social network non riesce a far trionfare un presidente (o viceversa a decretarne la fine) almeno produce il flusso multicolore di tante storie possibili, il grande romanzo di un’umanità chiacchierona e invadente che, minacciata dall’incomunicabilità, dalla separazione, dall’individualismo, ha trovato la via di fuga (o di salvezza, chissà) di una perenne, promiscua compagnia.

















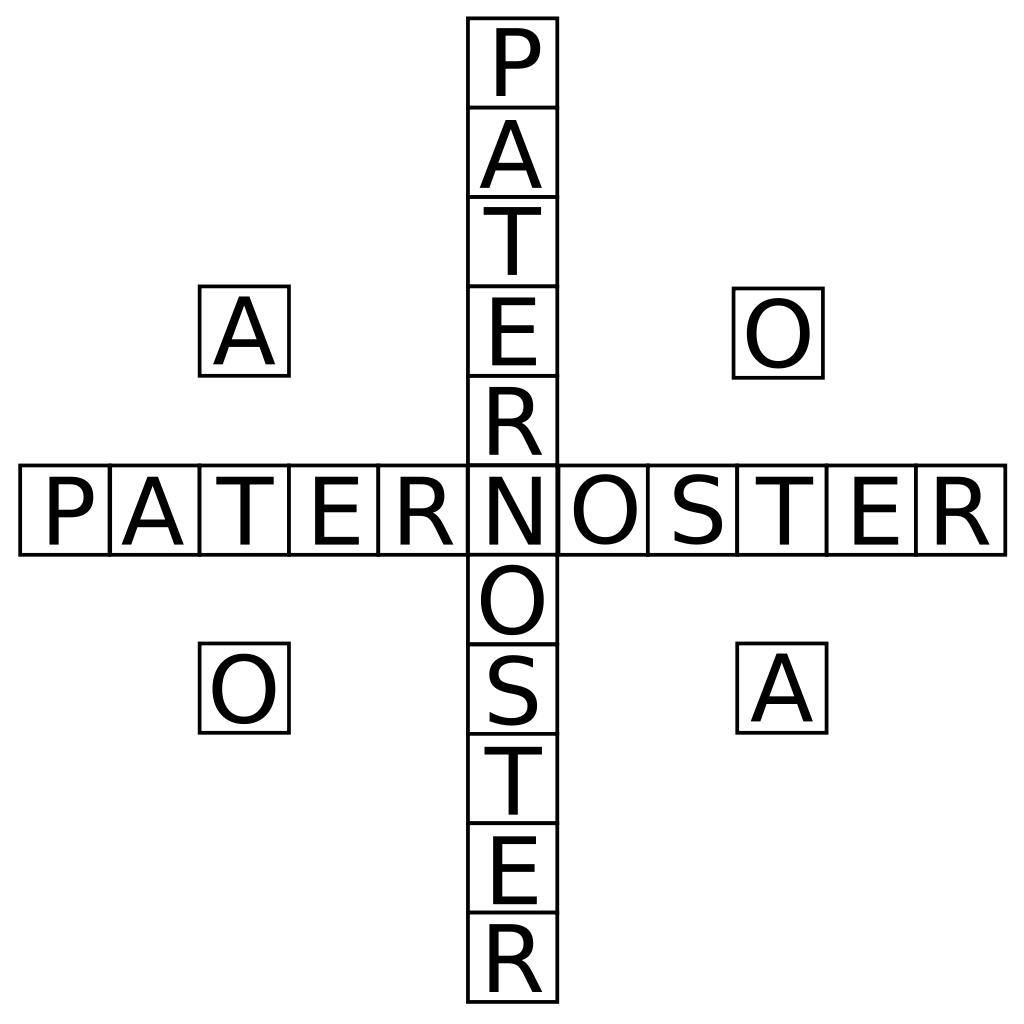
.jpg)