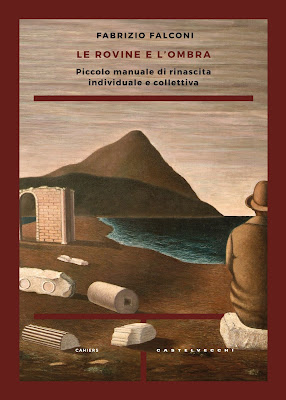LuigiComencini era considerato un autore popolare. Forse perfino troppo per la
critica militante: non gli si perdonavano i film d’esordio con Totò e la
Pampanini, ma il successo clamoroso del Pinocchio
televisivo gli aveva guadagnato consensi unanimi.
Del resto la sua formazione
era impeccabile: l’infanzia parigina, i trascorsi al Politecnico di Milano e
alla Cineteca Italiana (come curatore) ne avevano fatto uno dei più solidi
registi italiani. Nel 1972, fresco del
successo televisivo collodiano, Comencini aveva deciso di tentare il successo
definitivo all’estero, mettendo insieme un super cast nel quale si
fronteggiavano le due coppie: Alberto Sordi - Silvana Mangano e Joseph Cotten –
Bette Davis.
Rodolfo Sonego aveva scritto un copione
formidabile sulla follia del gioco e quando si trattò di pensare all’interprete
della vecchia miliardaria americana, grande e cinica giocatrice di carte,
Comencini tentò l’azzardo di rivolgersi alla diva americana. Bette Davis si
trovava in vacanza in quel periodo alle terme di Carlsbad nel sud della
California.
Quando ricevette il copione, si entusiasmò. Impulsivamente, com’era il suo carattere, prese
il primo aereo per l’Italia e firmò il contratto, accorgendosi soltanto in un
secondo momento – con notevole disdoro - che il film era girato in italiano.
Troppo tardi. La villa dove fu girato il
film – la residenza romana della vecchia miliardaria – era la splendida VillaMiani, a Monte Mario. La miserabile borgata dove vivono invece Sordi e la
Mangano, con i loro quattro figli e i loro stracci era quella di Via Anzio, alla periferia sud
di Roma, all’Arco di Travertino.
Comencini, sul copione di Sonego, allestì
una crudelissima fiaba sul gioco, sul valore dei soldi, sulla povertà e la
ricchezza: lo stracciarolo Peppino, e
sua moglie Antonia aspettano come ogni anno l’arrivo della vecchia miliardaria
americana che gira il mondo insieme al fedele autista George. Morbosamente appassionata di giochi di carte,
la vecchia ogni volta sfida i due poveracci (che si sono allenati per un anno
intero) allo scopone scientifico, un gioco che – come spiega il Professore (Mario Carotenuto) della
borgata ai suoi due allievi –
presenta miliardi di varianti possibili e che «su miliardi e miliardi di
partite, non mette mai in mano le stesse carte».
Anche stavolta i due sperano una buona volta
di sbancare il patrimonio della vecchia e dare una svolta alle loro vite e a
quelle di tutti quelli che vivono con loro nella borgata. Ma l’arpia ne sa una
più del diavolo. E dopo aver perso la cifra di duecento milioni, nell’ultima
partita che si disputa su quello che sembra essere il suo letto di morte, la
miliardaria rivince tutto, gettando i due sul lastrico.
Peppino ha sbagliato proprio nella mano
fatidica, a scartare la carta giusta. La
rovina si abbatte su di lui, non solo quella economica: Antonia, delusa
definitivamente dal marito, consapevole della sua inadeguatezza, lo tradisce con Righetto (Domenico Modugno), giocatore professionista
e baro smaliziato.
A Peppino tocca l’infamia di essere
considerato impotente al gioco e impotente nel ruolo di marito. Ma anche a Righetto
non va meglio. Quando sembra che
stavolta il fato giri dalla parte dei borgatari, la vecchia nell’ultima
partita, sbaraglia nuovamente gli avversari. Righetto perde i suoi ultimi
guadagni investiti, Antonia perfino la baracca che si è ipotecata.
Nel finale da melodramma, Righetto tenta il
suicidio, mentre Antonia e Peppino finiscono col riconciliarsi davanti a tutti
i compagni di borgata con la dichiarazione: «che m’emporta de la ricchezza..
basta che c’è l’amore!»
Ma il sottofinale amarissimo del film di
Comencini è affidato alla saggia figlia quindicenne Cleopatra, la quale ha già
visto tutto, sa già quello che succederà il nuovo anno, quando l’americana
tornerà un’altra volta a sconvolgere le loro vite e di nuovo il destino – che
non è caso e non è caos – si ripeterà immutabile. Per spezzare finalmente la
catena, Cleopatra, senza dir niente a nessuno mette il veleno per topi nel
dolce che è stata incaricata di preparare per la vecchia in partenza per
l’America.
È l’unico modo per rivoltarsi definitivamente contro i potenti, l’unico modo
per liberarsi dalla schiavitù (del gioco e del potere dei ricchi): quello di
ricorrere alla eliminazione fisica dell’avversario. E se questo sicuramente piacque poco al
pubblico americano (che lesse il film come un apologo sulla lotta di classe),
oggi dice molto sull’ombra personale (sotto forma del gioco), che se non può
essere evitata e se ritorna sempre a perturbare e sopraffare, va estirpata.
Durante la proiezione di quel giorno, al
cinema Augustus, il mio amico John a tratti se la rise di gusto, mentre durante
alcune scene – soprattutto le lunghe sequenze delle partite a scopone – rimase
con gli occhi ipnotizzati da quel che succedeva sullo schermo.
«Ha ragione Freud,”mi disse alla fine quando
si riaccesero le luci in sala, mentre scorrevano i titoli di coda».
In che senso, chiesi.
«Loro non volevano veramente vincere.
Peppino e Antonia».
«Come non volevano ?»
« Ma sì, non ti sei accorto ? Loro in fondo amano la vecchia. Amano lei e l’autista,
i loro carnefici. Per questo non possono mai vincere. La amano perché lei
rappresenta quello che loro non hanno e che non potranno mai avere».
Aveva ragione, ripensando alle immagini
iniziali del film, quando il nuovo arrivo della miliardaria è salutato quasi
come un trionfo dal popolo dei borgatari, con i cioccolatini e i dolci
dispensati da lei ai ragazzini e alle famiglie povere.
Ma che c’entrava questo col gioco ?
«Antonio è contento di perdere, perché in
questo modo può mettere alla prova l’amore di Antonia per lui. Non vuole
vincere veramente».
«E Cleopatra allora ?»
«Cleopatra no. La ragazzina forse è l’unica
che vorrebbe vincere veramente. Per riscattare la sua vita contro l’ingiustizia
di quei ricchi. Ma sa che i suoi genitori
non potranno mai vincere, e perciò preferisce ammazzare la vecchia».
«Quindi lo scopone scientifico è la metafora
del potere ?»
«No, non credo. Lo scopone scientifico è un gioco difficile
che sembra facile», disse John, «io l’ho imparato da mia nonna, una vecchia che
potrebbe reggere il confronto con Bette Davis.
Lei mi ha spiegato che il segreto dello scopone è solo quello di non stare sotto giro: non devi essere tu
il primo a scartare, nel giro. Ma devi essere sempre il primo a prendere. È un
problema di sottomissione».
Gli risposi che conoscevo il gioco anch’io e
che non è per niente facile non stare
sotto giro.
«Dipende dalle carte che hai in mano»,
dissi.
John sorrise:
«Ma come ha detto il Professore nel film, le combinazioni delle carte sono infinite,
sono miliardi di miliardi, e tu non avrai mai due volte le stesse carte. Il tuo
compito è quello di uscire dall’ombra. Con le carte che hai ogni volta, non
devi farti rinchiudere nell’angolo, cioè dover scartare ogni volta, cominciando
il giro. Con il rischio di non avere più carte buone, sicure in mano».
Facile a dirsi, molto difficile a farsi.
«Neanche i vincenti sono felici. Bette Davis
non era felice di vincere», aggiunse.
«Davvero ? Sembrava felicissima invece».
«No.
Lei vorrebbe perdere per essere umana, ma è costretta a vincere per assecondare
il suo demone».
Queste considerazioni filosofiche, per due ragazzi che erano alle prese con la scoperta
di Freud, aprivano scenari interessanti.
«E qual è il tuo demone ?» chiesi, mentre
tornavamo a piedi attraversando il Ponte Sant’Angelo che era già notte.
«Il mio ? È quello di tutti: la paura di
perdere …»
«Che intendi ?»
« I giocatori professionisti sanno che si
perde tutto quando hai paura di perdere …»
«Non si direbbe», puntualizzai, «anche
Righetto, che è un professionista, fa la fine degli altri due..»
«Perché anche lui ha paura di perdere. Ha
paura di perdere la sua reputazione e soprattutto l’ammirazione incondizionata
di Antonia che glielo ha fatto preferire al marito».
«E la vecchia ? Non ha forse paura ?»
«Sì anche lei ha paura, ma meno degli altri.
È vecchia, può morire da un momento all’altro. Ha meno da perdere».
Più tardi, tornati a casa, John tirò fuori
dal cassetto un mazzo di piacentine. «Questa è la Polla»,rise indicando l’Asso di denari: la grande aquila con le ali
aperte e il bollo d’imposta sul ventre, «dicono che quando arriva questa, vinci
di sicuro. Ma non bisogna mai fidarsi delle carte.. ricordati di Antonia e Peppino.
Ci hanno creduto … »
«Insomma, l’unico modo per vincere è perdere
… »
«Proprio così. Quando perdi o quando ti perdi, si imparano molte cose».
Sembravano parole incongruenti dette da lui,
che era sempre avanti a tutti, lui con i vestiti sempre appena usciti dal
guardaroba, il taglio di capelli impeccabile, la grossa moto con le marmitte
tirate a lucido, la collezione di dischi in ordine alfabetico, i panni rossi
sulle tastiere, la pila di libri da leggere, le giuste idee in testa, le contestazioni alla vecchia insegnante, la
sottile strafottenza di chi aveva visto di più e aveva vissuto molto, molto più
di noi.
L’immagine vivente del perfect guy.
Eppure anche questa bella immagine, si
incrinò. John, con il suo cognome italiano, e con il suo brillante futuro, fu
come ingoiato dalla spirale del tempo. Di lui si persero definitivamente le
tracce.
Le nostre strade si separarono, ma la sua
non so dove l’ha portato. Nell’epoca
della totale rintracciabilità, di lui non esistono nemmeno segnali digitali; ed
è ben strano, considerato quanto fosse interessato alla tecnologia.
Da lui ricevetti soltanto un biglietto,
diversi anni dopo il nostro ultimo incontro.
«Avevo ragione», c’era scritto, «i vincitori non sono mai felici».
Si riferiva al finale del film, quando una
immane tristezza si dipinge sul volto del giornalista Bill Denny (George Segal)
dopo che insieme al suo sodale, lo spiantato
Charlie Waters (Elliott Gould), ha sbancato il casinò di Reno, in
Nevada, vincendo 82 mila dollari.
Mi era chiara la rovina dei perdenti. Su
quella dei vincenti, invece, avrei voluto chiedere ancora molte cose al mio
amico.