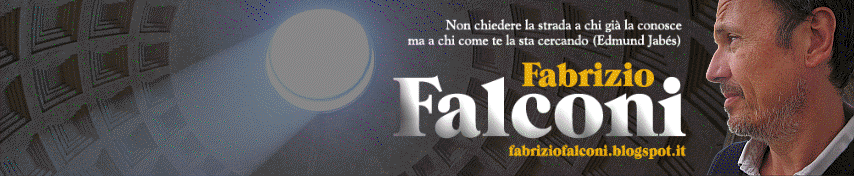La statua di Lord Byron a Villa Borghese
7. La statua di Lord Byron a Villa Borghese e i fantasmi
Figlio di un padre che non
conobbe mai e di una madre che lo asfissiò, ossessionandolo sia fisicamente che
psicologicamente, George Gordon Noel Byron, più conosciuto come Lord Byron,
nato a Londra nel 1788, divenne come è noto il più celebre poeta dei suoi
tempi. Non solo: la sua vita faticò molto a dividersi dalla sua arte: Byron
anzi fu in un certo senso il vero, perfetto dandy. Chiacchieratissimo da vivo per i suoi
scandali e per le continue eccentricità (come quando si fece rinchiudere nella
Cella del Tasso, a Ferrara o come quando attraversò a nuoto lo stretto dei
Dardanelli), Byron morì nel 1825 in Grecia, a Missolungi, in seguito a una
febbre reumatica contratta a Cefalonia, che degenerò in meningite delirante. E
proprio come accade per le rockstars
di oggi, la sua morte divenne un evento, lasciando inconsolabili fans a lamentarne la dipartita.
Poco tempo dopo la morte,
alcuni amici si misero insieme raccogliendo la somma di mille sterline per
commissionare una statua dello scrittore. Tra i vari scultori pretendenti fu
scelto il danese Bertel Thorvaldsen, il quale si trovava in quel periodo in
Italia.
La scelta non fu casuale: lo
scultore aveva già ritratto Byron vivo nel brevissimo e intenso soggiorno
romano del poeta a Roma, nel suo studio di piazza Barberini, per incarico di
John Cam Hobhouse, che del poeta era compagno di viaggio e studio. Con tanto di
lodi sull’artista da parte dello stesso Byron, il quale l’aveva definito nei
suoi diari «Il migliore dopo Canova, al quale anzi alcuni lo preferiscono».
Il busto, dopo varie
peregrinazioni, era finito a Londra nella sede della casa editrice di John
Murray, e fu dunque utilizzato come modello per la nuova e più grande opera.
La statua fu iniziata dallo
scultore nel 1829 ma Thorvaldsen impiegò molto tempo per completarla poiché,
proprio a causa della fama scandalosa che avvolgeva ancora la figura di Byron, fu
rifiutata da tutte le istituzioni che avrebbero dovuto ospitarla: il British
Museum, la Cattedrale di Saint Paul, l’Abbazia di Westminster e la National
Gallery, trovando finalmente la sua collocazione nel 1834 nella biblioteca del Trinity
College di Cambridge. Thorvaldsen contraddisse, non si sa quanto consciamente,
la volontà di Byron, che in vita, proprio avendo a cuore la promozione della
sua immagine, aveva chiesto agli artisti che lo effigiavano (erano
numerosissimi: il merchandising intorno a Byron aveva prodotto ritratti,
bassorilievi su medaglioni di marmo e perfino anelli con la sua immagine) di
ritrarlo non come un poeta, e cioè con il libro e la penna in mano, ma come un
“uomo d’azione”. Thorvaldsen, invece, raffigurò Byron proprio nella posa
classica dei poeti, seduto su di uno scranno di marmo, con un libro aperto
nella mano sinistra, la penna nella destra, poggiata sul mento.
La statua comunque, dopo le
difficoltà iniziali, ebbe grande successo e vi fu una produzione numerosa di
copie, nel corso degli anni, una in ogni città dove Byron aveva soggiornato:
una fu realizzata anche a Roma, inaugurata nel 1959, e si può ammirare nel cuore
di Villa Borghese, in via della Pineta.
Sul piedistallo della copia
romana, sono incisi brani tratti dal poema di Byron, Childe Harold Pilgrimage,
dedicati all’Italia:
of the world, the home
Of
all Art yields, and Nature can decree,
Even in
thy Fair Italy!
Thou
art the garden desert, what is like to thee?
Thy
very weeds are beautiful, thy waste
More
rich than other climes’ fertility;
Thy
wreck a glory, and thy ruin graced
With
an immaculate charm which cannot be defac’d.
Sullo scranno di marmo poi,
dalla parte sinistra sono raffigurati alcuni simboli esoterici: un teschio, un
gufo e due lettere greche, l’alfa e l’omega.
Il perché di questa
simbologia si spiega con l’enorme fascinazione di Byron per il mistero, che a
Roma, in quei ventidue giorni trascorsi nella capitale, aveva trovato terreno
assai fertile.
A Roma Byron arrivò nella
primavera del 1817, interrompendo un gaio soggiorno veneziano, proprio per
realizzare il sogno di vedere da vicino quella città che lo aveva sempre – da
lontano – ammaliato. Un medico infatti prescrisse al poeta di allontanarsi dall’umidità
veneziana, per guarire da un “mal di petto”. Byron non se lo fece ripetere e colse l’occasione
per realizzare il suo sogno, attraversando l’Italia con il suo corteo al
seguito, una carrozza con i sedili reclinabili e una quantità enorme di
bagagli.
Giunto nella capitale, andò
abitare nella centralissima piazza di Spagna, al numero 66. E non aspettò
nemmeno un minuto per cominciare a esplorare la città in sella al suo cavallo.
L’impressione che ne ricavò fu immediata e stordente: «Sono incantato da Roma
come lo sarei da una cappelliera di pizzi», scrisse al suo editore John Murray,
«e di Roma non vi dirò nulla: è indescrivibile. La guida qui vale più di ogni
altro libro. Ho passato tutta la giornata a cavallo…» (3).
Le sue peregrinazioni lo
portarono al Colosseo, al Pantheon, a San Pietro, sul Palatino e perfino fuori
Roma, a Frascati, Albano e Ariccia.
Byron sentì le rovine e i
monumenti come muti testimoni di una tragedia immane, popolati di presenze
ancora vive. Nel Pellegrinaggio di Aroldo
rievoca – come in una visione – l’episodio del gladiatore agonizzante nell’arena:
Stavo tra le mura del Colosseo,
In mezzo ai grandi resti della potente Roma.
Gli alberi che crescevano lungo gli archi spezzati
Oscillavano oscuramente nell’azzurro cupo della notte,
E le stelle splendevano tra gli squarci delle rovine;
Un cane da guardia latrava oltre il Tevere;
E più vicino, dal palazzo dei Cesari, veniva
Il lungo lamento del gufo e, a tratti,
Il canto inquieto di lontane sentinelle
Sorgeva e si smorzava sul vento leggero.
Un brano talmente straziante
che Stendhal, anche lui in quei giorni di passaggio a Roma, riprende nelle sue Passeggiate Romane, animandolo in una
notte di suggestiva luce lunare. (4)
E nell’arco di quei ventidue
intensissimi giorni, il dandy pallido e fascinoso ebbe modo anche di scoprire
il lato tragico contemporaneo di Roma. In un’altra lettera del 30 maggio di
quell’anno, sempre indirizzata a Murray, Byron descrive minuziosamente l’esecuzione
capitale cui gli accadde di assistere: riguardava tre ladri (erano, come risulta
dal puntiglioso diario di Mastro Titta, il boia: Giovan Francesco Trani, Felice
Rocchi e Felice De Simoni) decapitati nella piazza del Popolo con l’accusa di “omicidi
e grassazioni”. Byron racconta il
macabro spettacolo: i preti con la maschera, i carnefici mezzi nudi, i
criminali bendati, il Cristo nero e il suo stendardo, il patibolo, le truppe,
la lenta processione, il rapido rumore secco e il pesante cadere della lama, lo
schizzare del sangue e l’apparizione spettrale delle teste esposte. Tutto
questo, scrive Byron, «è nel suo insieme più impressionante del volgare rozzo e
sudicio new drop e dell’agonia da cani inflitta alle vittime delle sentenze». (5)
Forse fu proprio l’aver
assistito a questo spettacolo cruento uno dei motivi che spinsero Byron ad
interrompere presto il suo soggiorno a Roma: dopo ventidue giorni e notti di ruderi
e cavalcate, di frequentazioni dell’alta società romana e di soste al Caffè
Greco, il poeta decise di far ritorno al Nord, portandosi dietro i fantasmi di
Roma che ritornarono a farsi vivi nei suoi poemi.
Tratto da: Fabrizio Falconi, Roma Segreta e Misteriosa, Newton Compton, Roma, 2015
1. Il primo a parlare di una corrispondenza tra il profilo della
Villa Strohl Fern e l’Isola dei morti di Boecklin fu Gianni Rodari in Quel
pasticciaccio di Villa Strohl-Fern. La bistrattata isola di verde sopra
Piazzale Flaminio, «Paese Sera», 23 settembre 1975.
2. A. Trombadori, Villa
Strohl Fern, «Strenna dei Romanisti», 21 aprile 1982.
3. Vedi G. Scaraffia, Quella Roma di Lord Byron, «Il
Messaggero», 27 luglio 2015.
4. Vedi C. Rendina, Le notti di luna di Byron sospeso sui
misteri di Roma, «la Repubblica», 24 luglio 2007.
5. Vedi C. Rendina, ibidem.